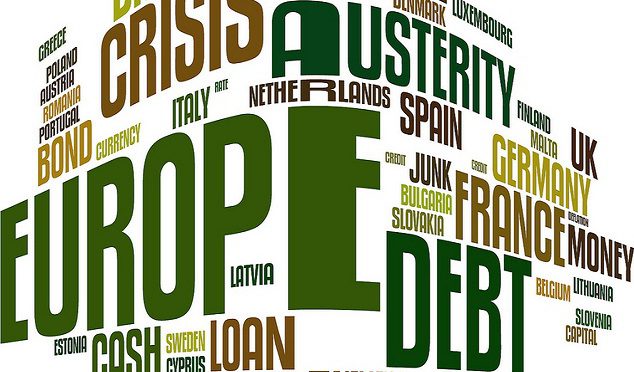Antonio Lettieri (da Eguaglianza & Libertà).
Antonio Lettieri (da Eguaglianza & Libertà).
Un decennio dopo la crisi il divario fra le economie di Stati Uniti e Eurozona è una condanna senza appello per le politiche che hanno fatto un feticcio del controllo dei conti pubblici a scapito della crescita e dell’occupazione. Se davvero l’Unione e l’euro si vogliono salvare quelle politiche vanno rottamate.
Mentre si avvia alla conclusione il secondo decennio del secolo è possibile tracciare un primo bilancio dopo la crisi globale che segnò l’autunno del 2008 in America. Da un lato, trova una conclusione la sfida commerciale fra stati Uniti e Cina con un compromesso. Una soluzione importante ma, probabilmente, provvisoria trattandosi di un contrasto per l’egemonia a livello globale destinato a durare e intensificarsi nei prossimi anni. Dall’altro, l’accentuarsi del divario fra le due maggiori economie capitalistiche: l’Eurozona e gli Stati Uniti. Vale la pena di soffermarsi su questo secondo aspetto che caratterizza i rapporti all’interno del mondo occidentale.
Da questo punto di vista, il decennio lascia in eredità un quadro di radicale divisione. Gli Stati Uniti si avviano a chiuderlo col più basso tasso di disoccupazione degli ultimi cinquanta anni, sia pure in un contesto di persistenti grandi diseguaglianze sociali. Al contrario, l’Eurozona chiude il decennio in un quadro di stanziale stagnazione quando non recessione.
L’Eurozona sembrava nel 2010 uscire dalla crisi con danni sopportabili, non molto diversi da quelli che avevano segnato gli Stati Uniti. Si trattò di una grande illusione. Nel 2011 le autorità che presiedono alla politica economica dell’Eurozona intrapresero un percorso che si sarebbe rivelato presto irragionevole. Per Jean-Claude Trichet che dirigeva la BCE, il pericolo maggiore non era, infatti, costituito dai postumi della Grande recessione ma dall’inflazione. La sua posizione, per quanto infondata, si coniugava con quella della Germania che, dopo i primi acciacchi della crisi nel 2008-09, rimaneva l’asse principale dell’economia europea.
In altri termini, si decisero due politiche opposte. Negli Stati Uniti un forte intervento pubblico diretto dalla Banca centrale guidata da Ben Bernanke e dalla nuova amministrazione di Barack Obama. Nell’Eurozona una politica recessiva all’insegna della coppia “austerità-riforme strutturali”. Il deus ex machina di questa poltica fu nel 2011 Jean Claude Trichet alla testa della BCE, che per ben due volte decise il rialzo dei tassi d’interesse, convinto che il problema non fosse il rischio di recessione, ma l’inflazione. La mossa successiva fu guidata dalla Germania di Angela Merkel che impose ai paesi dell’Unione il Fiscal compact, finalizzato a una poltica di azzeramento del disavanzo pubblico nel mezzo della recessione. Il contrario di una normale poltica di rilancio dell’economia.
Il seguito è ormai un capitolo di storia dell’Eurozona: è quello che appunto possiamo definire la Grande Divergenza all’interno dell’economia globale. L’attuale crescita prossima allo zero della Germania ne è la testimonianza più eclatante. Ma non si tratta solo del confronto della seconda potenza economica occidentale con gli Stati Uniti. La grande divergenza si rivela all’interno della stessa Unione europea. I paesi che ne fanno parte senza tuttavia partecipare alla moneta unica segnano una crescita economica significativa. In qualche caso, come in Polonia, una crescita intorno al 4 per cento, e, mentre la disoccupazione si riduce, il paese vede rientrare una parte dei polacchi emigrati negli anni della transizione e apre le porte all’immigrazione, particolarmente rilevante dall’Ucraina, pur discriminando quella medio-orientale e africana.
La Commissione europea, non ostante il cambio della guardia con l’avvento della presidenza di Ursula Von der Leyen, continua a professare una linea i rigore priva di qualsiasi fondamento in un quadro di sostanziale stagnazione economica dell’Eurozona. L’obiettivo rimane il pareggio strutturale del bilancio e la riduzione del debito. Obiettivi raggiunti da Germania e Olanda ma che rimangono una chimera per molti dei 19 paesi dell’Eurozona. Vi è infatti una parte di spesa pubblica incomprimibile oltre un certo livello di tolleranza sociale. Il risultato è un circolo vizioso: l’obiettivo dell’azzeramento del disavanzo di bilancio blocca gli investimenti, i consumi e la crescita in un quadro di elevata disoccupazione, facendo aumentare in alcuni paesi il rapporto fra debito pubblico e PIL.
Una poltica caratterizzata da contrasti paradossali, come nel caso del governo italiano che nell’autunno scorso ha dovuto fronteggiare la Commissione europea per stabilire un disavanzo del 2,2 al posto del 2.1 per cento considerato da Bruxelles un limite da non valicare. Tutto questo, mentre l’economia italiana chiudeva il 2019 con un crescita prossima allo zero e una disoccupazione mediamente intorno al 10 per cento per non menzionare il Mezzogiorno dove oscilla intorno ai doppio.
Da notare che, contemporaneamente, la Francia annunciava un disavanzo di bilancio del 3,2 per cento, ma non si poteva attaccare il governo di Macron provocando un ulteriore motivo di contrasto nella coppia franco-tedesca che sempre più viaggia su binari divergenti. In altri termini, la Grande Divergenza economica fra le due maggiori aree del mondo capitalistico si riflette in una crescente divergenza politica all’interno della stessa Unione europea, di cui la secessione della Gran Bretagna è una prova difficilmente sottovalutabile.
Eppure, le ragioni della crisi dell’Eurozona non hanno nulla di indecifrabile, se si pone una semplice domanda. E’ possibile comprimere il disavanzo di bilancio in un clima di stagnazione economica, quando l’’austerità, in coppia con le riforme strutturali, ha già eroso il confini dello Stato sociale, bloccato gli investimenti, impoverito le classi lavoratrici e la maggior parte dei ceti medi?.Un interrogativo che appare obbligato ma che difficilmente viene formulato, senza essere accusati di populismo alternativamente di destra o di sinistra.
Rimane, tuttavia, aperta la domanda: come è possibile che le classi dirigenti e la poltica al loro servizio siano indifferenti a questi dati di fatto? La risposta muove da una circostanza che è tenuta scrupolosamente in ombra. La “classe agiata” (The Leisure class), come fu definita più di un secolo fa in un famoso saggio di Thorstein Veblen, non ha sofferto le conseguenze di un’economia stagnante.
La grande finanza europea è indifferente alla stagnazione vivendo in un clima di successo lontana dall’economia reale. Ecco alcuni dati senza dubbio illuminanti. Il 2019 si è appena chiuso con guadagni finanziari che segnano record eccezionali. In questo quadro i principali paesi che hanno conseguito i maggiori guadagni dal mercato azionario sono stati la Cina e gli Stati Uniti con aumenti medi dei valori azionari rispettivamente del 36 e del 29 per cento. Un aumento eccezionale negli Stati Uniti con pochi precedenti.
Tuttavia, considerata la performance dell’economia americana, il risultato potrebbe non apparire sorprendente. Ma è, invece, sorprendente che all’interno del G7, il Gruppo delle economie capitaliste più avanzate, troviamo, subito dopo gli Stati Uniti, l’Italia con guadagni di borsa del 28 per cento, solo un punto dietro gli Stati Uniti, seguita dalla Francia ( 26%) e dalla Germania (25%). In altre parole, i tre principali paesi dell’Eurozona, sebbene fluttuanti negli ultimi due anni tra recessione, stagnazione e bassa crescita, hanno di gran lunga superato i guadagni di borsa delle rimanenti economie del G7: Giappone (18%), Canada (15%) e Regno Unito (12%).
La spiegazione più ovvia è che il progressivo azzeramento dei tassi da parte della BCE e poi il Quantitative easing promosso nel 2015 da Mario Draghi, presidente della BCE, con la messa a disposizione degli stati membri di circa 2.550 miliardi di euro, non si è tradotta in investimenti produttivi di beni e servizi, ma in larga misura in investimenti di Borsa. Si sarebbero potuti utilizzare per rilanciare gli investimenti pubblici sia un una forma diretta sia a sostegno degli investimenti privati. Il risultato sarebbe stato una crescita dell’economia reale e, nel medio periodo, una conseguente riduzione del rapporto fra deputo pubblico e reddito nazionale.
Si è seguita, invece, una poltica rovesciata che ha esaltato gli investimenti speculativi – con grandi profitti per coloro che potevano accedere ai prestiti bancari – non per effettuare investimenti nell’economia reale ma per profittare del boom della Borsa. Un quadro nel quale un intreccio cumulativo fra investimenti finanziari e aumento dei valori di Borsa, anche con il riacquisto di azioni proprie da parte delle grandi imprese, consentiva l’accrescimento dei valori azionari posseduti. Vediamo così che, dal punto di vista finanziario, la divergenza tra l’Eurozona e l’America si arresta traducendosi in una sorprendente convergenza.
Ma la Grande Divergenza riappare se si osserva il quadro economico e sociale. Alla crescita della ricchezza finanziaria dei ceti più ricchi si contrappone la crescita della disparità con i ceti medi, sui quali grava una condizione di sostanziale stagnazione economica, di bassi salari, di occupazione precaria quando non di aperta disoccupazione. Vediamo in questo quadro diminuire il reddito nazionale del cinque per cento nel corso del decennio.
Ma non basta. Le medie mascherano, a loro volta, divergenze ancora più eclatanti. Contemporaneamente, la ricchezza è aumentata ai livelli di reddito più alti, mentre la povertà si è diffusa tra i redditi medi e bassi. In particolare, è cresciuto in Italia il divario nei redditi medi fra il Nord e il Mezzogiorno, dove la disoccupazione è raddoppiata nel corso del decennio, sfiorando il 20 per cento della popolazione attiva. .
La crisi non significa che la costruzione dell’Unione europea – iniziata 70 anni fa con l’istituzione della CECA, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, sotto l’impulso della Francia, fosse sbagliata. O che l’istituzione di una moneta unica da parte di un gruppo dei paesi dell’Unione europea fosse necessariamente insostenibile. In effetti, l’origine e il fallimento dell’iniziativa non sono nell’adozione della moneta unica , ma nella politica nella quale l’unificazione monetaria è stata imprigionata.
Una politica che non è solo all’origine della Grande Divergenza fra Eurozona e Stati Uniti, ma anche di una crescente divergenza all’interno di ciascun paese dell’Eurozona fra una sempre più ristretta élite privilegiata, che opera sui mercati finanziari globali, e una grande massa si cittadini che l’austerità, imposta a livello nazionale dalle autorità europee, ha emarginato e impoverito.
Nuovi limitati barlumi di sinistra emergono in due paesi che hanno duramente sofferto la crisi come nel caso del Portogallo e della Spagna. Qui i partiti di centro sinistra e di sinistra, come Podemos, hanno assunto nuove responsabilità di governo. L’Italia è, invece, in una situazione incerta, sul crinale di una poltica di cambiamento ancora possibile, da un lato, e di una svolta a destra come risultato di elezioni anticipate, dall’altro.
Ma le previsioni, soggette negli ultimi anni a ripetute smentite, rischiano di essere un futile esercizio. La chiave del cambio di politica dell’Eurozona sta, da un lato, nell’abbandonare il vincolo della politica fiscale come obiettivo a cui la politica economica e sociale deve essere subordinata; e, dall’altro, nel ritorno al ruolo dello Stato come motore di crescita attraverso la rivitalizzazione degli investimenti pubblici e una nuova politica sociale progressista.
il problema non è nella moneta che si adotta. Usando il dollaro, gli Stati Uniti hanno vissuto negli ultimi vent’anni – la durata della vita dell’euro – una breve recessione nel 2001 seguita da anni di crescita lenta, poi da una forte ripresa, che a sua volta è stata seguita da una devastante crisi economica paragonata inizialmente alla grande depressione degli anni Trenta. E, infine, un lungo periodo di crescita. Tutto questo nel corso di due decenni, corrispondenti alla vita dell’euro, e usando, ovviamente, anche loro una valuta unica.
Una chiara dimostrazione che gli andamenti del sistema economico non dipendono dalla valuta utilizzata, ma dalla politica economica disegnata dal governo. Un dogma neoconservatore come quello imposto sull’area dell’euro non può che tradursi in una politica deflazionistica e in un fallimentare risultato economico e sociale.
La base del cambiamento è nel rottamare il pareggio del bilancio come obiettivo al quale subordinare la politica economica e sociale e il recupero del ruolo dello Stato come motore della ripresa, col rilancio degli investimenti pubblici anche come precondizione di ripresa di quelli privati. La riduzione del disavanzo e progressivamente del debito pubblico in rapporto al reddito nazionale possono essere solo un obiettivo di medio termine come riflesso della crescita economica e di nuovi equilibri sociali. E’ questo il quadro che dovrebbe impegnare tutte le forze progressiste per fermare l’inesorabile declino dell’Eurozona. In ogni caso, l’unica effettiva passibilità per salvare l’euro, se è ancora considerato un obiettivo comune.
Venerdì, 31. Gennaio 2020