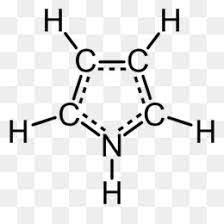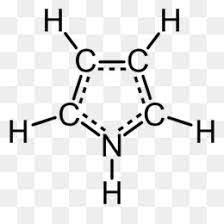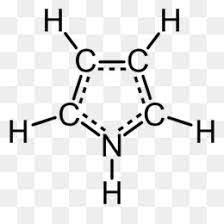 Tutt’altro che nuova alle attenzioni degli osservatori esteri, l’Italia è tornata recentemente a suscitare interesse per la sua positiva capacità di reazione alla crisi pandemica. Impossibile non ricordare gli elogi dispensati sul finire del 2021 dal settimanale “The Economist”, che l’ha consacrata “Paese dell’anno” non solo in ragione dei maggiori miglioramenti conseguiti in termini di qualità del governo e di gestione della pandemia, ma anche per aver dato prova di un più rapido avvio di ripresa del Pil. Con l’avvento del nuovo anno, tuttavia, un’analisi del quadro economico dei 23 paesi più “ricchi” dell’area Ocse da parte del medesimo settimanale, comprendente oltre al Pil anche altri indicatori significativi sullo stato di salute dell’economia, ha mostrato come in realtà il nostro paese sia ancora ben lontano dal poter cantare vittoria. L’Economist sottolinea come la pandemia “abbia creato vincitori e vinti” e l’Italia ricada tra i “worst performers”, avendo recuperato solo parzialmente le perdite subite sul fronte del reddito (complessivo e riferito alle famiglie), in un contesto nel quale il tasso di disoccupazione è molto più alto della media Ocse (9,2% contro 5,7%). Rispetto ai “blocchi di partenza” dell’inizio pandemia il Pil italiano – prosegue l’Economist – registra uno scostamento del -1,3%, contro i più ridotti scarti di Germania e Francia (rispettivamente -1,1% e -0,1%); differenze per la verità non preoccupanti se non fosse che il dato di confronto del 2019 corrisponde per l’Italia a un valore del 4% inferiore al livello del Pil precedente l’arrivo della crisi finanziaria internazionale del 2008.
Tutt’altro che nuova alle attenzioni degli osservatori esteri, l’Italia è tornata recentemente a suscitare interesse per la sua positiva capacità di reazione alla crisi pandemica. Impossibile non ricordare gli elogi dispensati sul finire del 2021 dal settimanale “The Economist”, che l’ha consacrata “Paese dell’anno” non solo in ragione dei maggiori miglioramenti conseguiti in termini di qualità del governo e di gestione della pandemia, ma anche per aver dato prova di un più rapido avvio di ripresa del Pil. Con l’avvento del nuovo anno, tuttavia, un’analisi del quadro economico dei 23 paesi più “ricchi” dell’area Ocse da parte del medesimo settimanale, comprendente oltre al Pil anche altri indicatori significativi sullo stato di salute dell’economia, ha mostrato come in realtà il nostro paese sia ancora ben lontano dal poter cantare vittoria. L’Economist sottolinea come la pandemia “abbia creato vincitori e vinti” e l’Italia ricada tra i “worst performers”, avendo recuperato solo parzialmente le perdite subite sul fronte del reddito (complessivo e riferito alle famiglie), in un contesto nel quale il tasso di disoccupazione è molto più alto della media Ocse (9,2% contro 5,7%). Rispetto ai “blocchi di partenza” dell’inizio pandemia il Pil italiano – prosegue l’Economist – registra uno scostamento del -1,3%, contro i più ridotti scarti di Germania e Francia (rispettivamente -1,1% e -0,1%); differenze per la verità non preoccupanti se non fosse che il dato di confronto del 2019 corrisponde per l’Italia a un valore del 4% inferiore al livello del Pil precedente l’arrivo della crisi finanziaria internazionale del 2008.
Aldilà di qualunque valutazione più o meno benevola, è dunque un fatto che l’economia italiana non ha ancora saldato i suoi conti con il passato. All’arrivo della crisi Covid l’Italia è l’unico paese dell’Eurozona (ad eccezione della Grecia) a non aver risalito completamente la china della trascorsa recessione. E andando a ritroso appare chiaramente come le sue difficoltà di crescita vengano da molto più lontano. Nel 2005 lo stesso Economist l’aveva presentata come “The real sick man of Europe” (Il vero malato d’Europa), zoppicante e ormai avviata sul sentiero del tramonto. Un’uscita che non doveva suonare inaspettata, visto che proprio allora iniziava ad animarsi fra gli economisti il dibattito sul “declino” del paese; questione tanto più discussa dopo il 2008 quanto più risultava evidente che i contraccolpi della crisi erano stati tra i più duri e che il terreno perso veniva riguadagnato molto più lentamente. Quella dell’Italia appariva sempre più una “crisi nella crisi” della quale veniva colta la natura essenzialmente strutturale, collegata soprattutto al persistere di una debole capacità di innovazione del suo sistema produttivo a causa della scarsa presenza di imprese nei settori tecnologicamente più avanzati. Questi ultimi divenuti sempre più cruciali per lo sviluppo mondiale via via che il rapido incremento delle conoscenze scientifiche innovava radicalmente gli assetti della produzione industriale grazie a un’attività di ricerca sempre più sistematica e condotta su larga scala.
Ciò che però sembra aver per lo più improntato l’industrializzazione italiana è l’idea che fosse percorribile la via di uno “sviluppo senza ricerca”, che è finita con il diventare la “bussola” alla quale sono state affidate le sorti dell’economia del paese. Emblematico in tal senso è stato il frequente ricorso alla metafora del “volo del calabrone”, una leggenda rivenduta spesso come “verità scientifica”, secondo la quale il tozzo insetto riuscirebbe a volare sfidando le leggi della fisica. Esattamente come l’Italia che, priva di risorse naturali e relativamente povera di industrie avanzate, contro ogni aspettativa avrebbe tessuto una storia fitta di successi, divenendo una delle maggiori economie mondiali. Nella realtà, tuttavia, e senza nulla togliere alla forza di un’ascesa che dalla seconda metà del secolo scorso ha sostenuto il decollo economico del paese, i sintomi di una fragilità del percorso di sviluppo intrapreso si sono fatti sempre più numerosi e frequenti. I limiti erano quelli di un’economia che, completata la prima fase della modernizzazione in coda ai paesi più industrializzati, non poteva sfruttare oltre la spinta propulsiva tipica del “paese inseguitore”, importando o adattando secondo modalità più o meno creative le tecnologie prodotte altrove e frutto di una continua e crescente attività di ricerca scientifica.
Non importa pertanto rilevare “solo” quanto a investimenti in ricerca (fermi ad appena 1,5% del Pil) e relativamente alla capacità di presidiare i mercati dei beni ad elevato contenuto tecnologico l’Italia si trovi oggi a gravitare verso la periferia dei maggiori paesi industrializzati e con ormai l’incombente presenza di quelli “di nuova generazione” (Cina in testa) che pure stanno divenendo protagonisti nello sviluppo di nuove tecnologie. E’ importante piuttosto capire fino in fondo cosa sia “andato storto”, capire come mai il divario tecnologico con il resto del mondo sviluppato non solo non si sia ridotto, ma abbia seguitato ad ampliarsi. E su questo versante è importante cogliere i tratti fondamentali della dinamica storica che ha caratterizzato la spesa in ricerca in rapporto al processo di industrializzazione. Così facendo, si osserva infatti che il paese non aveva fin dal principio rinunciato a progettare un “salto di qualità” del suo sviluppo, ma si trovava impegnato a promuovere un forte aumento dell’investimento in ricerca con grande attenzione per quella di base (indispensabile ad alimentare la produzione di nuove conoscenze), prefigurando un’espansione dell’industria nei settori chiave delle tecnologie di frontiera. Ma, già dalla prima metà degli anni Sessanta, il fallimento di un’illuminata “programmazione economica”, che sarebbe dovuta diventare fulcro di politiche di intervento volte ad incidere sulla struttura del sistema produttivo, lasciava che emergessero i primi deragliamenti di una “corsa al benessere” prorompente e che necessitava al più presto di un altro registro. Aumenti dei salari che superavano quelli della produttività, generavano incrementi significativi dei costi unitari del lavoro e comprimevano i profitti, con effetti negativi sugli investimenti. In assenza di miglioramenti della produttività derivanti dallo sviluppo di settori avanzati, la via breve alla competitività non poteva che essere quella di calmierare le retribuzioni, riorganizzando l’occupazione anche attraverso operazioni di decentramento produttivo e di precarizzazione della forza lavoro e, non ultimo, facendo ricorso alla svalutazione del cambio. Un meccanismo in seguito solo parzialmente corretto mettendo in campo una capacità di innovazione del tutto inedita che faceva perno sulle conoscenze “non formalizzate” di “distretti industriali” incardinati in un fitto tessuto territoriale di piccole-medie imprese, e destinati a trainare per molto tempo il comparto manifatturiero, ma che sempre meno sarebbero stati attrezzati a fronteggiare gli esiti degli ulteriori avanzamenti tecnologici connessi alla rivoluzione dell’elettronica e dell’informatica.
L’Italia che si affaccia agli anni Novanta, che si confronta con uno scenario di piena globalizzazione produttiva attraversato dai veloci ritmi del cambiamento tecnologico, e con mercati nei quali cresce vertiginosamente il peso delle produzioni high-tech, da più di un ventennio ha già di fatto realizzato una sorta di “fuga dalla ricerca”, segnata da un sempre minor protagonismo delle imprese (operanti in prevalenza in settori tradizionali) e da una ritirata del settore pubblico che si è tradotta anche in minori finanziamenti per la ricerca di base. Nel frattempo il Pil cresceva già a tassi inferiori a quelli dei principali paesi industriali, collocandosi su una traiettoria declinante. La crisi valutaria subentrata nel 1992 e la necessità di ristrutturare le finanze pubbliche per predisporre il paese all’entrata nell’euro, completavano il quadro. Le spese in ricerca (tanto sul fronte delle imprese quanto su quello dello Stato) non sono esenti da ripercussioni e si contraggono drammaticamente, raggiungendo in quel decennio i loro minimi storici. Tale arretramento, di per sé negativo, risulta addirittura letale non appena se ne considerino gli effetti a lungo termine: una debole capacità del sistema industriale non solo di produrre innovazione, ma anche di utilizzarla, rendendo sempre meno rilevante la spesa pubblica in ricerca (che viene ulteriormente ridotta) e l’offerta di “capitale umano” altamente qualificato (che tende via via a diminuire o a infoltire le fila dei cosiddetti “cervelli in fuga”). Un circolo vizioso che ancora oggi sta pregiudicando la possibilità di dare il giusto impulso agli investimenti in ricerca (a cominciare da quelli pubblici) e alla nascita di filiere produttive a più elevata intensità tecnologica, facendo sì che il paese continui a giocare (infruttuosamente) la propria competitività sulla riduzione del costo del lavoro, con riflessi molto pesanti anche sulla la componente interna della domanda.
In una recente intervista, il Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha sostenuto come il positivo apporto di finanziamenti provenienti dall’Europa attraverso il programma di rilancio post-Covid “Next Generation EU” debba essere certamente salutato con soddisfazione, ma debba soprattutto risuonare come stimolo affinché l’Italia torni realmente a destinare risorse più consistenti e stabili all’attività di ricerca, a cominciare da quella di base. Il richiamo di Parisi coglie effettivamente un punto nodale. La storia della “fuga dalla ricerca” dell’Italia è infatti una vicenda che si contraddistingue anche per l’ampia variabilità delle cifre destinate alla spesa in ricerca e per la residualità con cui spesso queste sono state contestualizzate nelle politiche di bilancio. Ciò significa che l’investimento in ricerca ha perso da tempo anche il suo valore strategico e che, nel momento in cui si riconosce la necessità di tornare a investire, è necessario farlo avendo presente che esso deve diventare un pilastro della politica economica, della quale una politica industriale finalizzata al potenziamento dei settori tecnologicamente avanzati – che nell’attività di ricerca hanno il loro fondamento – diventi parte integrante. Una prospettiva, questa, che troverebbe riscontro anche nell’ambito di un rinnovato contesto europeo nel quale si sta valutando la possibilità di valorizzare il ruolo di quegli investimenti pubblici giudicati più rilevanti per il loro impatto strutturale sullo sviluppo economico, con crescente considerazione per gli interventi orientati all’innovazione dei sistemi produttivi.
7 febbraio 2022
“Articolo 33”
 Con il suo ultimo libro, “Democrazia sotto assedio”, attraverso 50 brevi lezioni di politica economica, Emiliano Brancaccio mostra il vero volto del capitalismo di oggi, destinato a sopprimere la democrazia perché somiglia sempre più al vecchio feudalesimo
Con il suo ultimo libro, “Democrazia sotto assedio”, attraverso 50 brevi lezioni di politica economica, Emiliano Brancaccio mostra il vero volto del capitalismo di oggi, destinato a sopprimere la democrazia perché somiglia sempre più al vecchio feudalesimo