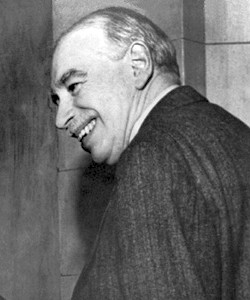di Sergio Ferrari (da www.cittadellascienza.it)
4 marzo 2016

Tra le varie domande che le incertezze economiche esistenti sollevano a livello internazionale, la più frequente – anche se non sempre espressa compiutamente – sembra essere quella che riguarda i tempi e i modi del superamento delle cause della crisi da tempo in atto.
Una crisi che ha evidenti connotati economici, ma non minori sono i segnali negativi in materia sociale, ambientale e delle relazioni internazionali. Segnalare e accentuare i toni su un aspetto piuttosto che su un altro, non aggiunge nulla a quella condizione di incertezza generale. Peraltro è ovvio che quando le difficoltà economiche superano un determinato livello è impossibile che quel contesto non venga investito da altri fattori di crisi e dal peggioramento anche di indicatori sociali e culturali.
Un accentuato paradosso di questa situazione consiste nel fatto che nonostante i quotidiani riscontri negativi, il ricorso a terapie para-liberiste sembrano andare sempre per la maggiore. Se esiste una condizione di evidente incoerenza tra le ipotetiche e miracolistiche leggi del libero mercato e la realtà che viviamo e alla quale si vorrebbero applicare – e, quel che è peggio, da tempo si applicano – questa dovrebbe consistere proprio nella crisi che da anni le società dei paesi sviluppati stanno, pur in varia misura, vivendo. Affrontare i singoli problemi con un approccio liberomercantilistico è, a dir poco, contraddittorio con la natura macroeconomica delle questioni.
Uno dei punti di vantaggio di queste posizioni errate deve essere riconosciuto nella forte debolezza delle proposte alternative, molto spesso formulate più come ripetizione dei problemi da correggere che come interventi definiti nei tempi, nei modi e nei costi. Il che naturalmente non rende né convincenti né positive le ricette proposte.
Come affrontare questa necessità di capire gli attuali meccanismi di funzionamento e quindi delle sue difficoltà ad affrontare questioni che, come si vedrà, hanno sempre più una dimensione complessiva e interconnessa, è questione che certamente non può essere risolta da questo intervento. Qui sarà possibile segnalare solamente alcune questioni, oltre a tutto e comunque discutibili, ma che potrebbero offrire, anche criticamente, qualche occasione di verifica e di approfondimento ed assumere cosi una qualche valenza propositiva.
Tutto questo ci dice intanto che non si è di fronte ad una delle solite crisi cicliche del capitalismo ma ad una di quelle crisi strutturali che implicano cambiamenti nei meccanismi sociali, nelle relazioni economiche e nella scala dei valori di riferimento.
A sua volta la natura strutturale di questa crisi non si può ridurre solo ad una constatazione, ma sollecita anche e prioritariamente l’individuazione delle cause, da ricercare nelle trasformazioni del sistema capitalistico cosi come si è evoluto. Sapere qual è la malattia è la premessa per immaginare una terapia corretta, tuttavia quando la malattia non è ancora nota – come nel caso in questione – sono evidenti le difficoltà e, quindi, la necessità di uno studio, in genere, prolungato.
Nei decenni del 900 il capitalismo ha vissuto una sua epoca certamente di gran successo. Non solo avendo sconfitto il suo antagonista più pericoloso, cioè il comunismo, ma anche perché ha saputo diffondersi e allargarsi coinvolgendo ex novo un paio di miliardi di persone, diventando di fatto l’unico sistema economico vivente.
Se non che ci sono anche i lati negativi e, ad esempio, se lungo questo percorso ha saputo trovare le forme per accrescere anche il livello economico della classe operaia, con varie resistenze, contraddizioni e inversioni di marcia, sul fronte delle differenze di ruolo sociale, assolutamente nulla è stato fatto. La questione merita una riflessione ulteriore. I cambiamenti economici nei livelli retributivi si sono accompagnati ad un avvicinamento a quelli del così detto ceto medio, a sua volta fortemente ampliato sul piano numerico ma non su quello, appunto, retributivo. Si assiste dunque, a situazioni in altri tempi considerate inimmaginabile quali, ad esempio, quella di una persona che carica una batteria in un’officina con un livello retributivo che può essere superiore a quello di una borsa di studio di un ricercatore, probabilmente a sua volta con impegni orari quantitativamente maggiori. E non si tratta di casi singolari.
Nel frattempo occorre considerare un andamento crescente a livello mondiale della popolazione lavorante in termini convenzionalmente capitalistici, con una presenza percentualmente crescente della quota di popolazione che si colloca nel cosi detto ceto medio.
Questioni come queste non sono necessariamente in contrasto con le attraenti previsioni formulate alla fine degli anni ’20 da parte di Keynes e in particolare con la sua previsione di poter lavorare, tra circa cento anni, per 15 ore la settimana, e inoltre, di aspirare a questa quota di lavoro necessario residuo, essendo stato tutto il resto del lavoro necessario attribuito a macchine, robot, ecc. e essendo rimasto il resto del tempo disponibile dedicato ad un’elevazione culturale e “al godimento di una forma di beatitudine economica”.
Una previsione, questa di Keynes, basata sul confronto della proiezione degli andamenti della domanda con l’aumento della produttività del lavoro e relativa a quei “bisogni assoluti” cioè a quei “bisogni che sentiamo tali, quali che siano le condizioni degli esseri umani nostri simili”. Gli altri bisogni sono sì inesauribili, ma appartengono alla categoria dei “bisogni relativi” nel senso che “esistono solo in quanto la soddisfazione di essi ci eleva, ci fa sentire superiori….” .
Essendo non molto lontani dalla scadenza centenaria prevista da “quell’aristocratico leninista”, come giustamente Lunghini chiama Keynes, non sarebbe male incominciare a fare un po’ di conti, delle verifiche e qualche riflessione.
Intanto è giusto ricordare che Keynes per raggiungere quei traguardi evidenzia un assunto e pone quattro condizioni. L’assunto consiste nel fatto che “ dal secolo XVI è incominciato, proseguendo con crescendo interesse nel secolo XVIII, la grande era delle invenzioni scientifiche e tecniche che, dall’inizio del secolo XIX ha avuto sviluppi incredibili….”. Su questa questione si tornerà nel seguito solo per evidenziare una trasformazione essenziale di questo “sviluppo”. Le quattro condizioni di Keynes erano espresse in questi termini: la capacità di un controllo demografico; la determinazione nell’evitare guerre e conflitti civili; la volontà di affidare alla scienza la direzione delle questioni di sua stretta pertinenza; il tasso d’accumulazione; il conseguimento di quest’ultimo “verrà da sé una volta conseguiti i primi tre”.
Sul controllo demografico le verifiche possibili sono più che positive ai fini espressi da Keynes dal momento che si prevede il raggiungimento di una situazione sostanzialmente stazionaria entro il secolo corrente: Questo implica, tra l’altro, il superamento della dannazione delle carestie che hanno accompagnato per secoli la riflessione economica e sociale, formalizzata in varie pubblicazioni compreso il testo di riferimento scritto alla fine del ‘700 da Daniel Malthus con il Saggio sul Principio della popolazione. L’ipotesi fondamentale di quel saggio si basa sulla previsione di fasi di carestia in attesa di recuperare capacità produttive alimentari ormai insufficienti, per poter riprendere uno sviluppo. Attualmente esistono aree di forti carenze alimentari ma sappiamo tutti che le cause non sono quelle indicate da Malthus, quanto nella cattiva distribuzione sul pianeta delle risorse esistenti, che come tali sarebbero più che sufficienti per tutti.
Una cattiva distribuzione alimentare che si accentua in concomitanza con gli andamenti straordinariamente negativi raggiunti con riferimento alla seconda condizione posta da Keynes, cioè la determinazione nell’evitare guerre e conflitti civili. Su questo tema la società internazionale nel secolo passato non si à fatta mancare nulla con conseguenze, sia sul piano demografico sia su quello delle condizioni di vita, che andrebbero ricordate almeno come deterrente.
Gli effetti negativi di quelle devianze non si esauriscono nel breve periodo, basti pensare, ad esempio, al fatto che secondo opinioni diffuse e dotate di evidenze empiriche, l’uscita dalla crisi economica del 1929 si ebbe in parte con il superamento del liberismo e la scoperta dello stato sociale, ma questo superamento divenne definitivo solo grazie al ricorso ad un’economia di guerra negli anni ’40, un conflitto mondiale tra i più tragici conosciuti nella storia dell’umanità a sua volta causato da una vicenda “culturale” che lascia esterrefatti i lettori attuali. Ma dopo quelle situazioni traumatiche è venuto il lungo periodo di “equilibrio del terrore”, anche questo ad un certo punto superato, “liberando” così una marea di conflitti locali, civili, di superamento delle condizioni coloniali, di “sistemazione” di vecchie contese, ecc. ecc. sino alle più recenti manifestazioni di relazioni internazionali da “sterminio divino” quali forse nemmeno 500 anni fa si sono verificate.
Tuttavia il tema della guerra è attualmente sottovalutato per il motivo che non riguarda più, almeno come attori principali, i paesi europei. La nostra cultura eurocentrica non solo non evidenzia questa realtà ma appare anche incapace di gestire il proprio ruolo e gli stessi effetti che pur le si scaricano contro, essendo peraltro parte della causa.
Il capitalismo ha dimostrato una straordinaria flessibilità adattandosi, con le sue regole fondamentali in materia di produzione di profitto, a pressoché ogni regime politico. Naturalmente questo non è un titolo di merito in assoluto né una garanzia di successo sempre e dovunque. Il capitalismo potrebbe rispondere ricordando come solo per merito suo un paio di miliardi di uomini si stanno inserendo nel sistema economico capitalistico dove ci saranno degli squilibri distributivi e situazioni meritevoli di ampie correzioni, ma certo non peggiori di quelli preesistenti di stampo medioevale. La validità di una tale risposta è del tutto limitata nel senso che anche Marx ne riconosceva l’esistenza ma questo nulla toglieva e toglie alle critiche di ordine storico strutturale rivolte allora e in seguito a quelle soluzioni economico-sociali.
Occorre ricordare, infatti, che nella critica al capitalismo, due erano le osservazioni di fatto mai confutate e cioè, come prima critica, l’esistenza di una distribuzione della ricchezza tra capitale e lavoro, consentendo al lavoro solo la sua sopravvivenza da “proletario”, la seconda che nella scala delle decisioni del cosa e come fare c’era chi era preposto a comandare e chi ad ubbidire. Le contraddizioni in materia di attribuzione dei ruoli sociali, inoltre, non solo sono rimaste inalterate ma sembra che vadano manifestandosi in termini crescenti con una progressiva concentrazione dei vertici ma, soprattutto, con una concomitante scoperta dell’economia finanziaria come forma di recupero di capacità di creare profitto, senza nemmeno più preoccuparsi dell’economia reale. Se questa dovesse essere l’unica possibilità per sopravvivere, questo segnerebbe una sconfitta accelerata e finale del capitalismo.
Una spinta nella direzione di una progressiva accentuazione della dimensione critica della cattiva distribuzione dei ruoli sociali viene proprio dagli effetti di quella distribuzione dei redditi da salario che hanno unificato la vecchia classe operaia con il ceto medio, eliminando quelle condizioni che avevano giustificato la denominazione di “proletario” . Oggi in tutti i paesi avanzati la dimensione di questo nuovo ceto medio è grandemente maggioritaria, ma trasformazioni della distribuzione dei ruoli sociali non sembrano essere all’orizzonte.
Anche una concomitante riduzione dell’orario di lavoro non potrebbe “compensare” una conservazione di queste condizioni. Non si tratta di sottovalutare la negatività di un processo di cattiva distribuzione della ricchezza che in anni recenti sembra aver assunto una dimensione generale e tale da richiamare l’attenzione e la critica anche di economisti non di scuola marxista. Un’attenzione per un aspetto del modello economico capitalistico, ma che come tale conferma una “dimenticanza” verso la persistente e inalterata distribuzione dei ruoli sociali. Questo anche in considerazione delle logiche connesse a quell’altra condizione posta da Keynes e cioè “la volontà di affidare alla scienza la direzione delle questioni che sono di sua stretta pertinenza”. Un’affermazione che, se si vuole andare al di là dell’ovvietà, merita qualche approfondimento.
Volendo precisare quali siano le questioni di pertinenza della scienza è necessario considerare che, in maniera via via crescente, sempre più dalla scienza dipende la nostra vita quotidiana. Appare del tutto ragionevole considerare la ricerca scientifica come appartenente a quelle attività da collocare, sempre utilizzando la terminologia keynesiana, tra quelle che assicurano “la nostra destinazione di beatitudine economica”. Tuttavia occorre anche considerare che l’accumulo delle scoperte scientifiche ha dato luogo alla creazione non solo di conoscenze ma anche – e sempre più sarà così – di un accumulo delle conoscenze e questo accumulo ha una proprietà che è quella di consentire di programmare l’innovazione e il cambiamento.
Si tratta di prendere atto che lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha via, via costituito un bagaglio anche di capacità tecnologiche e, nel complesso, ci ha dotato di uno strumento di sviluppo mai prima esistente. Questo ruolo implicito di attore economico da parte della conoscenza scientifica è via, via, diventato e sempre più diventerà esplicito. Le trasformazioni tecnologiche radicali non avranno più una scadenza estemporanea come effetto di singole manifestazioni di nuove conoscenze scientifiche, ma saranno prevalentemente effetto di decisioni di istituzioni sociali, potendosi dedicare le risorse esistenti ad una pluralità di obiettivi da valutare opportunamente. E’ evidente che tutto questo pone un problema di confine tra il tempo per il lavoro necessario e quel tempo da dedicare ai bisogni inesauribili “il cui godimento ci eleva e ci fa sentire superiori.”.
Dove collocare il tempo dedicato alla scienza, alla cultura e, a maggior ragione, il tempo dedicato a come collegare queste attività a quelle che assicurano i bisogni “esauribili”, sarà il sale di quella nuova condizione sociale. Fermo restando l’importanza della conoscenza scientifica, senza la quale il decadimento complessivo sarebbe inevitabile, si apre e si conferma la necessità di immaginare una partecipazione del tutto nuova per il sistema sociale, una partecipazione alla programmazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, senza la quale non sarebbe immaginabile una società civile e democratica. Come, in che termini definire e organizzare questa partecipazione, ci sarà tempo per dare le necessarie risposte, essendo chiaro che su questa questione si può discutere del come ma non del se.
Per ora, quindi, ci si può limitare a citare alcune questioni che andranno via via, chiarite. La prima riguarda la stretta contiguità tra le varie fasi del processo innovativo, tra le fasi iniziali di pura conoscenza scientifica e quelle finali di realizzazione di un prodotto/servizio: si parte dalla libertà della ricerca e della conoscenza scientifica per arrivare ai brevetti o a sistemi di protezione della proprietà intellettuale.
D’altra parte se la progressiva eliminazione delle disuguaglianze, che non siano quelle derivanti dalla libera scelta dei soggetti, deve assicurare la fruizione di beni in qualche misura comuni e se quelle quindici ore di lavoro settimanale debbono assicurare il giusto contributo dei singoli, le assicurazioni sulla proprietà intellettuale, brevetti, ecc., potrebbero essere ridiscusse sino al loro venire a mancare. Ma anche in questo caso l’articolazione della produzione sul territorio è tale da indurre delle diverse ricadute sulla distribuzione territoriale delle ricchezza. L’utilizza delle matrici economiche, che gli economisti deviati dal liberismo hanno dimenticato, potrà tornare utile anche a questo scopo e correggere così queste differenze. In secondo luogo la necessaria programmazione sociale dell’innovazione tecnologica porta con se la programmazione anche di quelle attività che dovranno concorrere alla nostra “beatitudine economica”.
La crescente esistenza ed evoluzione della conoscenza scientifica e tecnologica quale strumento per lo sviluppo della società si accompagna ad un altro processo di cambiamento di ordine sociale, forse, ancora più importante e cioè il cambiamento del ruolo sociale di quanti nella scala dei valori sino ad ora era collocato tra gli “ ubbidienti”. Sui criteri di distribuzione della ricchezza prodotta l’azione storica dei partiti di sinistra e delle OO.SS. hanno introdotto, pur con alti e bassi, delle modifiche importanti talché attualmente il capitalismo deve riconoscere livelli retributivi e condizioni di lavoro del tutto simili tra l’operaio e quello che viene chiamato il “ceto medio”. Ma questa convergenza economica implica necessariamente una convergenza sociale e culturale.
Questa evoluzione sembra essere coerente con quella esigenza di partecipazione sociale accennata poco sopra come conseguenza dell’evoluzione dello strumento della programmazione dell’innovazione e, quindi, della valenza strutturale delle possibili riforme. Mentre dunque nel dibattito sui difetti e sugli errori del capitalismo, sembra essere sotto esame sempre e solo la dimensiona economica della distribuzione della ricchezza, si apre una nuova prospettiva che finalmente affronta la seconda questione e cioè la separazione tra chi comanda e chi ubbidisce .
L’aumento della produttività del lavoro che, seguendo Keynes, ci potrebbe consentire di lavorare 15 ore alla settimana, può avere alti e bassi ma certamente si basa su indicazioni e osservazioni valide allora coma attualmente. L’unica questione che occorre tenere presente è che quel risultato keynesiano non è detto che si verifichi dovunque e con la stessa intensità. Basta scorrere le cause possibili di quel processo – tra cui lo sviluppo dell’innovazione tecnologica – per capire come sia possibile una varietà di comportamenti molto elevata Ad esempio anche solo confrontando l’andamento della produttività del lavoro espressa in termini di variazione del PIl per ora lavorata, relativa a paesi che dovrebbero essere molto simili quali Germania Francia e Italia si notano andamenti molto differenziati: un andamento in buona misura molto omogeneo nel periodo dal 1971 al 1982 ma che in seguito tende a differenziarsi sino ad indicare, per questi ultimi anni nel caso del nostro paese, un andamento pressoché negativo. Questa differenza, che si riflette sull’andamento del PIL nasce dalla metà degli anni ’80 e tende ad aumentare.
Come si vede questo andamento non è attribuibile alla crisi internazionale, che ha date di origine e di sviluppo del tutto differenti. Unificare queste due crisi nel caso del nostro Paese risponde solo al tentativo di nascondere le cause – e le scomode responsabilità – del nostro declino. Tra queste un peso non indifferente è rappresentato proprio dalle diverse capacità di fare ricorso alla scienza per ottimizzare i corrispondenti risultati economici. Se questo è rilevabile tra paesi “sviluppati” si possono immaginare gli spazi ancora aperti in tutti quei paesi che vengono collocato tra i paesi cosi detti “emergenti”.
Tutto questo naturalmente non smentisce la previsione di Keynes ma “semplicemente” evidenzia la necessita di una lettura del futuro molto attenta al presente. Un caso clamoroso, ma del tutto ignorato, di questa scarsa attenzione è rappresentato della vicenda della sostenibilità ambientale sul fronte della immissione dei gas serra, da un lato, e la conseguente politica energetica, dall’altro. Sul primo fronte l’attenzione e gli impegni internazionali corrispondono a studi internazionali sul fenomeno e ad accordi internazionali che impongono crescenti misure di contenimenti nelle emissioni di quei gas.
Una tappa molto attesa e molto citata si è avuta nel recente dicembre 2015 con la Conferenza di Parigi. In parallelo ci sono stati altri convegni internazionale, ad esempio da parte dell’Opec, dove le previsioni sull’andamento dei consumi di prodotti petroliferi avevano un andamento tale da confermare gli andamenti precedenti senza che si potesse rilevare un effetto delle politiche ambientali discusse a Parigi.
Niente di strano, si dirà, ma se sono veri come lo sono, gli allarmi per le modificazioni climatiche, così come sono vere le esigenze vitali dei paesi produttori di petrolio, sembra lecito considerare che nonostante il livello delle istituzioni chiamate in gioco, uno scambio e tanto meno una ricerca di soluzioni congiunte, non si sia nemmeno tentato. Ci si sarebbe aspettato che quelle istituzioni internazionali cosi elevate avrebbero preso in considerazione con i pericoli ambientali connessi con le emissioni da combustione dei prodotti petroliferi, anche l’esistenza di una economia delle fonti energetiche da combustibili fossili che al momento regge la sopravvivenza di alcune centinaia di milioni di persone.
Per essere chiari non s’intende richiamare la necessità del conseguente cambiamento tecnologico – che pur meriterebbe qualche attenzione – ma una presa in carico delle “pesanti” conseguenze su specifici paesi che sulla produzione di combustibili fossili hanno la loro principale risorsa economica, la loro sopravvivenza. Per non ricordare i paesi che soffrono delle variazioni climatiche senza nemmeno poter disporre dei connessi vantaggi commerciali.
Il paradosso dei paradossi è che quando questi paesi produttori di idrocarburi organizzano una loro risposta con un più che dimezzamento dei prezzi, tutto questo si risolve senza che nessuno avverta la messa in crisi di quelle politiche energetiche sollecitate da Convegni come quello di Parigi: le due questioni – ridurre il consumo di prodotti petroliferi e coinvolgere nel cambiamento le economie interessate – continuano ad essere due questioni separate. Se le istituzioni e le imprese non sono capaci di affrontare questioni cosi vitali e ovvie – pur se contraddittorie – occorre cambiare questi attori se non si vogliono perdere le occasioni di evitare i conflitti.
Come affrontare questioni di questa natura e cioè problemi che interessano in termini fondamentali ma contradditori un gran numero di paesi, è una componente di quella condizione keynesiana necessaria per raggiungere il risultato positivo finale e cioè la “ determinazione nell’evitare guerre e conflitti civili “. Forse Keynes pensava a questa condizione quando indicava la necessità di “por mano a qualche modesto preparativo“, aggiungendo: “guardandosi dal sopravalutare l’importanza del problema economico o di sacrificare alle sue attuali necessità altre questioni di maggiore e più duratura importanza.”. Qualche anno dopo, quando venne chiamato a definire gli accordi internazionali per avviare la ricostruzione post-bellica, non a caso la sua proposta conteneva la creazione di una moneta unica a livello mondiale.
Una proposta bocciata e sostituita con la decisione di assumere il dollaro, convertibile in oro, come moneta di riferimento per tutti i paesi. Una soluzione di rilevo politico ridotto – come confermato dalla sua conclusione nel 1971 – e non dissimile da quella, altrettanto modesta, assunta alla fine degli anni ’80, in occasione della definizione degli accordi per la costruzione dell’Europa, con la creazione di una Banca Centrale senza i poteri di assicurare un comportamento articolato coerente con lo sviluppo economico degli Stati partecipanti, essendo preminente l’obiettivo di assicurare la tenuta di bilanci da parte dei soci, con i conti a posto come quelli di un’azienda. Qualcuno rilevò da subito la “stupidità” di tale impostazione e la contraddizione tra questo approccio contabile e gli ideali che erano stati alla base della creazione dell’Europa.
Quella stupidità ebbe una riprova clamorosa quando un Paese importante culturalmente ma debole economicamente come la Grecia venne costretto a operare entri i limiti “aziendali” sopra ricordati, sottoponendo quel paese a condizioni di tale pesantezza da metterne in discussione la possibile appartenenza all’Europa, piuttosto che “spendere” pochi miliardi di euro che avrebbero disturbato la cultura del contabile. L’aver trasformato il Progetto europeo in una segreteria di ottimi ragionieri non contribuisce certamente a far crescere il “ritmo” del nostro percorso virtuoso.
Il richiamo di queste due vicende – quella relativa alla contraddizione tra la firma degli Accordi sul contenimento delle emissioni nell’atmosfera e quella relativa alle vicende della Grecia in Europa – piuttosto che vicende passate dalle quali sono nati eventi bellici, intende segnalare una questione significativa e cioè la permanenza dei potenziali conflitti che potrebbero nascere tra paesi, quando il livello gestionale delle relazioni e dei corrispondenti trattati internazionali è inferiore a quello richiesto per far prevalere le soluzioni di reciproca comprensione.
Casi di questa evidenza possono essere numerosi e tutti significativi nel senso di essere potenziali minacce belliche: basti pensare all’attuale soluzione di contenimento delle emigrazioni da aree già in conflitto. Anche in questi casi la capacità e la lungimiranza delle Istituzioni sono una componente necessaria per attuare soluzioni positive, ma non sempre il loro sguardo e i loro poteri sono adeguati ai problemi da affrontare, sopratutto se non esiste una diffusa sollecitazione per quel tipo di società pronosticato da Keynes. La pretesa di affrontare i problemi con l’ottica miope del breve periodo, è evidentemente un’ottica non solo priva di senso, ma che non assegna nessun valore a quella società pronosticata da Keynes, nessun valore a quei “bisogni inesauribili” senza i quali l’immagine dell’umanità non potrà che essere quella di un mondo primitivo.
Parlare di rispetto dell’ambiente, del piacere di ascoltare la musica, di andare per il mondo, di fare una corsa in bicicletta, di costruire un monumento, di dedicarsi ad un’attività di creazione artistica o artigianale, di partecipare ad una vicenda collettiva, ecc, dovrebbe certamente prevalere nella volontà e nell’azione di tutti, rispetto al richiamo della violenza.
Come è ormai evidente la possibilità del raggiungimento di quello “stato di beatitudine”, sta essenzialmente nella capacità di alimentare e far crescere la nostra “determinazione nell’evitare guerre e conflitti civili”. Il controllo demografico e le questioni di pertinenza della scienza offrono andamenti potenzialmente coerenti con quel percorso, ma guardando a ritroso la storia dell’umanità la determinazione nell’evitare i conflitti bellici non sembra essere una vocazione particolarmente fiorente: ieri come oggi esistono situazioni per le quali la guerra riesce ad assumere una dimensione etica e quasi divina. Sono, infatti, esistite e continuano ad esistere situazioni “locali” che assumono la soluzione violenta come una delle possibili soluzioni di un possibile contrasto.
Occorre anche aggiungere che se per il controllo demografico si sono sviluppate anche potenzialità d’intervento accettate e accettabili e se il dominio della scienza ha accentuato le potenzialità della liberazione dal lavoro a vantaggio delle relazioni sociali, nel caso delle capacità di evitare conflitti sino ad ora si possono vantare casi positivi limitatamente a specifiche circostanze, ma molto meno e, forse nulle, in termini di capacità di mettere in moto metodologie generali automatiche e non tardive capacità d’intervento.
Al di là dei limiti manifestati dalle Istituzioni in termini di scarsa lungimiranza ma anche di scarsi poteri attribuiti, occorre analizzare questa relativa assenza di sensibilità per il verificarsi di eventi bellici a fronte dello sviluppo di quelle due condizioni che, invece, potrebbero portare verso atteggiamenti diversi a favore di quella crescita richiamata da Keynes.
In questi ultimi secoli la partecipazione ad una guerra non è stata una scelta considerata necessariamente in termini negativi, anzi molto spesso era un’occasione da non perdere anche a livello popolare. Sovente tanto più un conflitto aveva obiettivi ultramondani tanto maggiore era la violenza messa in campo. Se le possibilità di una libera scelta erano comunque nulle, tuttavia il peso di questo obbligo non era particolarmente grave date le condizioni di fatto esistenti.
È, dunque, ragionevole assumere che a fronte di “una condizione di beatitudine economica” quale quella pronosticate da Keynes, si dovrebbe sviluppare grandemente quella determinazione nell’evitare guerre e conflitti civili.
Un primo passaggio in questa direzione potrebbe consistere nel considerare il “prossimo” non più un potenziale nemico ma un attore e un protagonista di quella nuova condizione. Una condizione che senza la ricchezza delle diversità non potrebbe assicurare i valori della libertà, senza la presenza di quel “prossimo” non potrebbe pensare di avvicinarsi allo “stato di beatitudine”. E tra questi “prossimi” occorre collocare prioritariamente quelli di natura religiosa. Dobbiamo allora considerare che quei “diversi” sovente sono tali in quanto non possiedono nessuno di quei beni che ci collocano in un mondo superiore e ben pochi anche di quei beni essenziali per tutti, ma lo sono dal momento che assumiamo a riferimento i principi dell’eguaglianza e della libertà. .
In una situazione ancora di approccio a quello stato si può ricorrere, per ridurre il ricorso alla violenza e ai conflitti, a quanti – e non sono pochi – hanno maturato il principio della coerenza tra strumenti e obiettivi. Questa è stata una conquista maturata nella seconda parte del secolo scorso, spesso trascurata poiché ancora troppi sono coloro che sono arrivarti in ritardo su questi valori. Tuttavia lo spazio geopolitico coinvolto in questo percorso positivo è importante. In questo spazio ci dovrebbero essere, almeno in buona misura, i paesi dell’Unione Europea se si recupera il progetto iniziale di porre tra i primi obiettivi dell’Unione quello di ridurre le divergenze strutturali tra i vari attori, dedicando nel contempo una parte delle risorse nella partecipazione a più ampie convergenze internazionali.
Per ora le politiche comunitarie navigano su principi e con criteri del tutto fuorvianti con il rischio di essere attori negativi dal punto di vista delle relazioni internazionali oltre che sul fronte sociale e culturale interno. Ma questa stagione dell’Unione Europea condotta all’insegna dei valori del ragioniere è ormai superata e deve essere preparata urgentemente la prossima.
Affrontare i problemi attualmente aperti con questo nuovo approccio potrebbe effettivamente contribuire a contenere quelle che oggi sembrano minacce più o meno potenziali, di conflitto internazionale. Nel frattempo quelle trasformazioni socio-economiche che si concretizzano nella crescita della partecipazione e distribuzione delle responsabilità sociali, potranno trovare, a loro volta, una spinta se sapremo accrescere quel patrimonio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Se anche non si fosse ancora raggiunto la beatitudine economica, si potrebbe sempre sperare di essere su quella strada.
1) Un aggiornamento del Saggio sulle classi sociali di P.Sylos Labini del 1974, sarebbe quanto mai utile.